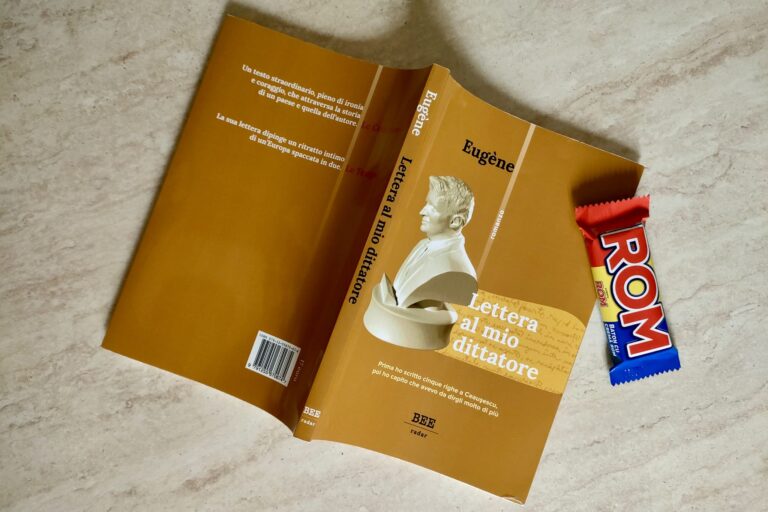Di recente uscita, Tahiti: Utopia di Michal Hvorecký arricchisce il catalogo di Wojtek Edizioni. A diciassette anni da XXX (2008), lo scrittore slovacco ritorna nelle librerie italiane con un romanzo uscito in lingua originale nel 2019. Oppressa dal dominio austro-ungarico, la Slovacchia cerca un futuro migliore traslocando l’intero paese sull’isola di Tahiti, con l’obiettivo di creare una nuova patria libera. Lo scenario paradisiaco si tramuta però ben presto in distopia.
Hvorecký rappresenta una delle figure di spicco del panorama culturale e sociale del suo paese, nonché uno degli autori più prolifici. Oltre alla sua attività di scrittore engagé, è anche traduttore dal tedesco e vanta la traduzione di opere del noto autore tedesco Martin Pollack.
Con Tahiti: Utopia Michal Hvorecký ha già da tempo raggiunto una significativa notorietà all’estero, come testimoniano le numerose traduzioni del romanzo. Abbiamo incontrato l’autore per chiedergli di raccontarci dei suoi progetti e del suo romanzo.
Ciao Michal, grazie per aver accettato di prendere parte a quest’intervista. Vorrei iniziare chiedendoti come sei diventato uno scrittore.
Scrivo da quando ho quindici anni. Ho iniziato in modo naturale e spontaneo. Ho sempre detto di voler diventare uno scrittore, vivere e lavorare coi libri, scrivere, tradurre. Non sapevo solo come figurarmi questo futuro. Nella nostra famiglia i libri hanno sempre giocato un ruolo fondamentale. Anche mio nonno e mio padre hanno scritto dei libri, sebbene accademici, soprattutto manuali, dispense e testi specialistici.
Vengo da una famiglia di scienziati. Credo nella ragione e nella conoscenza. Anche le donne della mia famiglia sono accanite lettrici, mia mamma, mia zia e mia nonna. Sin da bambino sono stato circondato dalla finzione, dalla narrativa, dal raccontare storie: prima le fiabe e poi i miti, più tardi i racconti e i romanzi. Egon Bondy1 è stato il primo a dirmi che avrei dovuto diventare seriamente uno scrittore, che avrei dovuto farne la mia professione. Per lui rappresentava una scelta fondamentale. Mi ha aiutato molto a definire il mio essere scrittore.
La Slovacchia è un contesto letterario che fatica ancora a imporsi nel mercato editoriale italiano. Forse alcuni di coloro che leggono questa intervista non ne conoscono le peculiarità. Come autore, sei emerso dopo la fine del comunismo e dopo il divorzio di velluto. Come descriveresti l’attuale scena letteraria slovacca?
È una letteratura relativamente giovane, scritta in una piccola lingua slava. Ha una storia particolare perché per molto tempo si è sviluppata sotto l’influenza di culture molto più antiche e grandi, difatti gli autori slovacchi scrivevano anche in latino, tedesco, ungherese o ceco. Nel Ventesimo secolo ha attraversato due totalitarismi, quello di Hitler e quello di Stalin, la censura, la repressione. Da questa esperienza emergono anche i suoi migliori autori e autrici, come Dominik Tatarka, Langerová o Ján Rozner. Hanno trasformato esperienze di vita terribili in una produzione letteraria meravigliosa e hanno ottenuto, almeno in parte, un riconoscimento internazionale.
Quando leggo e studio la letteratura del secolo scorso, percepisco una differenza rispetto a quella contemporanea, come se l’individualità dell’autore fosse più forte. Forse una generazione letteraria può essere identificata solo retrospettivamente e, tra cinquant’anni, parleremo di Michal Hvorecký come di uno degli autori della “generazione post-velluto”. Ovviamente si tratta di un’etichetta ironica. Pensi che sia possibile parlare di una nuova generazione di autori slovacchi?
Di certo appartengo a quella generazione plasmata dagli anni Novanta. È stato un periodo che mi ha segnato profondamente, nel bene e nel male. Diverse persone a me vicine ne sono uscite segnate, alcune sono addirittura morte a causa delle droghe pesanti. È stata un’epoca difficile. Le regole non erano ancora stabilite, tutto sembrava possibile. Al tempo stesso, scoprivo nuovi mondi: la techno e l’opera, il cyberpunk e Beckett. Ero giovane. Per la prima volta viaggiavo all’estero. Anche se non provo nostalgia, sono stati anni meravigliosi. Ho iniziato a organizzare eventi culturali, soprattutto legati alla letteratura e alla musica. Vivevo e creavo più intensamente possibile.
Cercando su internet, ho trovato una vecchia intervista in cui ti chiedevano se fossi il “Rudiš slovacco”2 . Ovviamente questa non è la mia domanda, conosco abbastanza Rudiš e i suoi libri per rispondermi da sola. Tuttavia, avete in comune un forte legame con la cultura tedesca. Qual è il tuo rapporto con la cultura ceca e con gli autori cechi?
Sono nato nel 1976 in Cecoslovacchia. Quella era la mia patria e, in un certo senso, lo è ancora. Sono cresciuto con la cultura cecoslovacca, anche con la sua letteratura. Per undici anni sono stato amico di Bondy, che mi ha introdotto alle opere di artisti come Toyen, Boudník, Váchal o Ladislav Klíma, ma anche di Janáček, Hegerová e dei The Plastic People of the Universe3. Ancora oggi mi piace molto andare a Brno, Olomouc, Praga, České Budějovice…
Di recente, al Teatro Studio Hrdinů di Praga, è stato presentato il tuo spettacolo Zabít člověka (Uccidere un uomo) che è ispirato a L’armata a cavallo di Isaak Babel’. Ti andrebbe di parlarmi di questo progetto?
Si tratta del mio libro preferito. In ceco divenne un vero e proprio culto, colpevole la geniale traduzione di Jan Zábrana4. L’armata a cavallo è una raccolta di racconti di Isaak Babel’, autore originario di Odessa. Partecipò alla campagna bolscevica rivolta a occidente, contro la Polonia. Per fortuna, anche allora la Russia perse la guerra. L’esportazione russa della brutale rivoluzione negli anni Venti del secolo scorso fu respinta con successo. La vendetta sovietica sull’Ucraina arrivò poco dopo sotto forma di una carestia deliberata. È un testo di grande attualità ed è con grande piacere che ne ho tratto una pièce teatrale per un eccellente teatro indipendente di Praga.
Oltre a essere autore, sei anche traduttore dal tedesco. Che differenza vedi tra queste due attività?
Non sono un traduttore molto attivo. Da noi non si può vivere di questo lavoro. Traduco a malapena un libro all’anno, sinora ne avrò tradotti dieci: Robert Walser, W. G. Sebald, tre libri di Martin Pollack, due di Judith Hermann… È un lavoro duro, ma bellissimo. Per me è fondamentale che la traduzione sia adeguata. Ho davanti un originale perfetto e devo trasporlo nella mia lingua madre. Mi dà gioia, ma è anche una grande fatica.
Molti dei tuoi libri sono stati tradotti in tedesco, ad esempio Dunaj v Amerike (Il Danubio in America) o Trol (Troll). Abbiamo parlato spesso dell’importanza del rapporto tra traduttore e autore: intervieni nella revisione della traduzione quando si tratta del tedesco?
Sono in stretto contatto con il mio traduttore in tedesco, che è diventato un caro amico. Quando lavora a un libro, mi pone sempre molte domande, si sofferma su ogni dettaglio e gli piace verificare ogni sua scelta linguistica. Lo apprezzo moltissimo. Adoro questo lato della nostra collaborazione, perché i traduttori sono i lettori più attenti. Ogni volta scopro qualcosa sul mio stesso manoscritto di cui non mi ero reso conto. Gli sono molto grato per il suo lavoro, così come per ogni altra traduzione in lingua straniera. Ormai, se non sbaglio, sono quattordici. Di recente il libro è stato pubblicato anche in ebraico e in polacco.
Ancora sulla questione della cultura tedesca: hai tradotto un autore molto importante non solo per la letteratura, ma anche per la memoria del mondo di lingua tedesca, Martin Pollack. Nella sua narrazione storica a mosaico, Pollack ci insegna ad ampliare la nostra prospettiva nazionale sulla memoria (se ricordo bene, in Topografia della memoria c’è anche un passaggio su un pastore slovacco). Tuttavia, credo che l’aspetto più significativo del suo lavoro risieda nella decostruzione del binomio vittima/colpevole, mettendo in luce l’importanza dello spettatore. Cosa ti ha colpito della sua opera?
Mentre lo traducevo, mi chiedevo spesso come fosse stato possibile che tutto quel male fosse potuto accadere, come fosse stato possibile che l’umanità lo avesse permesso. Gli eventi di oggi – il bullismo nei confronti di persone innocenti su internet, la costante ricerca di nemici, la ripetizione ossessiva di menzogne evidenti, la diffusione incessante di odio verso gli altri – purtroppo ricordano il periodo tra le due guerre mondiali.
Sono molto felice del fatto che la testimonianza e l’opera di Martin Pollack, grazie alle traduzioni, siano giunte a un pubblico più ampio anche in Slovacchia. I suoi libri e le sue idee hanno il potere per risuonare con forza proprio in questi tempi in cui stanno riemergendo molte di quelle tendenze radicali negative che hanno tragicamente segnato la storia della sua famiglia.
Clicca qui per altri articoli sulla Slovacchia
Di recente hai anche partecipato alla realizzazione del documentario Martin Pollack: Pohľad do priepasti (Martin Pollack: Uno sguardo nell’abisso) legato al libro Il morto nel bunker. Ti andrebbe di parlarmi di questo progetto?
È stata la mia prima esperienza professionale come attore in un film. In passato avevo già collaborato a qualche soggetto e sceneggiatura, ma questa volta si è trattato di qualcosa di completamente diverso. Paradossalmente, sono entrato nel progetto come interprete dal tedesco, e alla fine sono diventato uno dei due protagonisti principali. Le condizioni di salute di Martin Pollack si sono aggravate durante la preparazione al punto che non ha potuto affrontare il viaggio programmato sulle tracce del suo libro Il morto nel bunker. Così, con il suo consenso, l’ho sostituito in qualità di suo traduttore in slovacco.
Questo viaggio è stato una fonte di ispirazione. Abbiamo attraversato un pezzo di Europa centrale, dai bunker dell’Alto Adige – dove non ero mai stato prima in vita mia – fino al Burgenland meridionale, dove lo scrittore ha vissuto, fino alla regione slovacca di Liptov, dove abbiamo cercato i memoriali delle fosse comuni e parlato con gli ultimi testimoni. Quei crimini furono commessi dal padre biologico di Martin, l’ufficiale delle SS e della Gestapo Gerhard Bast, insieme ai suoi soldati. Il presidente fascista slovacco e sacerdote cattolico Jozef Tiso lo decorò con un’onorificenza statale per le sue azioni.
Mi sembra che la memoria sia anche un tema importante per te, e una delle tue opere si intitola Spamäti (Frammenti di memoria, 2013), non a caso. In una intervista, hai detto che l’hai scritta in cinque anni e che questa è “diversa dalle altre”. In che senso? In questo libro affronti la dimensione della storia dal punto di vista personale. L’hai definita “il mio ritratto”, puoi spiegare cosa intendi?
È una mia autobiografia frammentaria. Una storia su come sono diventato autore e su ciò che ho vissuto durante i miei viaggi nel mondo con i libri.
Poiché la tua opinione è così forte nei tuoi romanzi, devo chiederti del tuo impegno come pubblicista. Quanto è importante oggi in Slovacchia che uno scrittore si occupi anche di questioni politiche o sociologiche? Qual è il ruolo dello scrittore oggi in Slovacchia?
La mia scrittura è sempre stata anche politica. Negli anni Novanta ho cominciato a partecipare regolarmente a manifestazioni. Da più di dieci anni vi intervengo anche con dei discorsi. Ora la situazione si è complicata. Viaggio in tutta la Slovacchia e parlo nelle manifestazioni in favore di una cultura libera e per la democrazia, contro la censura e l’orientamento verso la dittatura russa. Scrivo per giornali, spesso anche austriaci o tedeschi, commentando gli eventi.
Credo che il risanamento della società slovacca possa avvenire proprio tramite la cultura e l’istruzione. La letteratura e la politica sono sempre state strettamente legate nel nostro paese. Anche Tahiti: Utopia contiene un messaggio politico contro il fanatismo nazionalista e a favore della convivenza solidale di diverse lingue ed etnie.
Come abbiamo già accennato, la Storia è un tema. molto importante per te. Nella graphic novel Súdruh disident (Compagno dissidente), scritto insieme a Matúš Vizár, racconti la storia di Milan Šimečka. Perché proprio Milan Šimečka? Come è nata questa idea?
Si tratta di una graphic novel incentrata un filosofo perseguitato dal regime. Šimečka, scomparso nel 1990, era un utopista. Credo che oggi in Europa manchi il coraggio di proporre idee visionarie e innovative come le sue. Spero che, grazie al nostro libro, le persone possano scoprire la sua vita avventurosa e la straordinarietà del suo pensiero. Tra l’altro, un tempo era piuttosto conosciuto anche in Italia: i suoi scritti venivano pubblicati su importanti quotidiani e i suoi libri suscitavano dibattiti, soprattutto tra i circoli della sinistra italiana. In effetti, Šimečka era originariamente un marxista, ma il regime lo incarcerò, nuocendo gravemente alla sua vista e alla sua salute. Dalla prigionia a Praga non si riprese mai completamente.
Nella graphic novel vi sono temi importanti come le utopie dell’ideologia socialista. Avete utilizzato anche documenti e immagini dell’epoca, quale è oggi l’eredità del comunismo in Slovacchia? Pensi che sia arrivato il momento per un’elaborazione profonda del passato “recente”?
Sarebbe necessario. La Slovacchia è ancora all’inizio di un processo di confronto critico con il proprio passato. Siamo stati complici di due crudeli dittature. Tra l’altro, ci lamentiamo spesso del fatto che non abbiamo delle élite, o che quelle che abbiamo sono poche. Eppure, figure come Milan Šimečka sono conosciute da ben pochi. Per me, proprio lui rappresenta uno dei modelli positivi e ispiratori del ventesimo secolo. Šimečka sosteneva che gli slovacchi e le slovacche avessero semplicemente “navigato” attraverso la Storia, senza prendervi attivamente parte.
All’inizio ti ho chiesto come sei diventato scrittore, ora vorrei parlare del futuro. Su quale libro stai lavorando adesso?
Mi piacerebbe scrivere un libro in tedesco che tratti delle condizioni a cui è giunta la Slovacchia in questo anno di crisi, il 2025, e sul perché la ministra della cultura ha sporto denuncia contro di me e contro molti altri autori.
È da poco uscita la traduzione di Tahiti: Utopia per Wojtek Edizioni. Anche in questo libro ti occupi della Slovacchia e di una versione alternativa della storia. Questo distacco dalla realtà ti permette una visione storica o sociologica più chiara?
Dopo la cupa distopia di Troll, ho scritto un romanzo utopico. Il libro è colmo di umorismo e ironia, ma affronta anche temi seri. Il protagonista è Milan Štefánik: politico, astronomo, seduttore, viaggiatore, poeta, diplomatico, pilota da caccia e il primo generale francese dell’Europa orientale, che amava e conosceva bene anche l’Italia. Mi sono a lungo chiesto: e se l’Europa centrale fosse completamente diversa? Nel mio libro esiste ancora la Grande Ungheria, ma non la Slovacchia. Mi piace quel genere letterario che esplora le alternative della Storia. Spesso mi chiedo: cosa sarebbe successo se…? Per esempio: se Trump non fosse diventato presidente o se Putin morisse domani?
Quando leggo molta letteratura ceca e slovacca, ho l’impressione che sia fortemente attratta dall’esotico. Forse questa mia percezione è influenzata dal fatto che ho una passione per l’avanguardia e una delle mie poesie preferite è di Konstantin Biebl5. Non lo so. Come ti è venuta l’idea di ambientare il romanzo a Tahiti? Perché proprio Tahiti?
Štefánik comprava per davvero appezzamenti a Tahiti e progettava di realizzare lì un’utopia, portando in paradiso il suo popolo oppresso. Peccato che non ci sia riuscito! Il mondo può essere diverso, almeno nei libri. Oggi le persone hanno di nuovo bisogno di utopie.
Tutti i nostri consigli di lettura oltre il meridiano 13 nella sezione libri
Note:
Tahiti: Utopia di Michal Hvorecký, traduzione di Matteo Annecchiarico, Wojtek Edizioni, 2025